Padre Aldo Bergamaschi
Da “Adesso”, rivista fondata da don Primo Mazzolari, 1° maggio 1962
La Pasqua che egli dona
L’alba, il vespro, la notte, hanno sempre un loro capitolo nelle avventure umane. Forse la narrativa occidentale deve molto alla cronaca evangelica che sigla la Passione e la Risurrezione di Cristo.
Nel Vangelo la collocazione temporale e spaziale degli avvenimenti non ha lo scopo di suggestionare la fantasia dei lettori o di polemizzare contro qualcuno; ma di bloccare la fantasia sull’orlo dei fatti e di raccontare il finale di una polemica che non è, né si risolve, come le solite diatribe tra uomini e ideologie.
Se polemica c’è, non è nell’ordine delle rivendicazioni, ma nell’ordine della salvezza. Non ci sono “vinti e vincitori”, vittorie e sconfitte, ma testimoni e testimonianze. Cristo non opera in un paesaggio astratto, né fuori del tempo, per testimoniare la verità e per salvare gli erranti: entra nel folto del “nostro tempo” e del “nostro spazio”.
Se a qualcuno sembra strano che ci sia un orario e un itinerario doloroso a scandire il passo di Colui che è nell’ordine dell’Essere pensi che soltanto così, sbriciolato nel nostro divenire – fatto di strade e di meridiane – possiamo vederlo con gli occhi che misurano lo spazio e con la mente che percepisce il tempo.
Si mise a tavola con i dodici “venuta la sera”. Tutti si scandalizzeranno nella notte “questa notte”. Quando Giuda esce dal cenacolo, dopo aver preso il boccone, “era notte”. Pietro rinnegherà “prima che il gallo canti”. Il passaggio dalla casa di Caifa al Pretorio avviene “di buon mattino”.
Gli anziani del popolo, convennero “come fu giorno”. Quando Gesù sale in croce è “quasi l’ora sesta”. Si rimette nelle mani del Padre “verso l’ora nona”. Maria Maddalena corre al sepolcro “alla prima luce”.
I due di Emmaus invitano il pellegrino a fermarsi perché “si fa sera e il giorno già declina”. Gesù è sulla riva del lago “venuto il mattino”. Consegna la sua pace “a vespro” del primo giorno dopo, il sabato.
I personaggi da romanzo, hanno bisogno di essere introdotti in un’ambiente minuziosamente descritto e preparato. Nessun romanziere avrebbe perduto l’occasione per descrivere la fuga di Giuda avvolto dalle tenebre o il sudore di sangue in un ambiente lunare drammatizzato dal canto dell’usignolo.
All’alba della risurrezione non sarebbe mancato il canto degli uccelli e la descrizione dello stato d’animo delle pie donne. La narrativa posteriore, e oggi la cinematografia, si esaurirà su particolari che il Vangelo fissa soltanto per onestà professionale. Quando l’alba e il vespro diventano oggetto di racconto, siamo fuori della storia.
Nessuna cronaca è più essenziale e obiettiva del Vangelo. Niente, nella storiografia umana, è più fotografato della passione e della risurrezione di Cristo; eppure niente è più lirico e più drammatico. Forse è l’unico caso in cui il Vero, il Buono, il Bello sono in congiunzione perfetta.
Se un romanziere avesse potuto immaginare il dramma finale del Cristo (che dramma finale non è) anzitutto non avrebbe osato farlo morire con tanta evidenza per non rendere assurda la Risurrezione; quanto poi a Cristo che entra a porte chiuse, ammesso che un romanziere avesse potuto immaginare la scena, l’avrebbe immancabilmente fatto entrare con un colpo di spalla.
Il Signore invece non rompe niente: né la sindone né la pietra del sepolcro, né le porte sprangate. La materia non può essere un ostacolo per chi l’ha creata. E se egli entra come una vibrazione sonora non è forse la Parola che, uscita dal seno del Padre, attraversa i cieli per posarsi nel nostro cuore di carne?
Se il modo di entrare è magnifico (senza rompere niente!) non è meno magnifico il modo di presentarsi. Non dice che ha vinto, non invita alla riscossa, non parla di pace, non predica la pace, non augura la pace, dona la pace.
Se mostra le mani bucate e il fianco aperto non lo fa alla maniera del “miles gloriosus”; ma per ammonire un incredulo. Quei fori sono documenti necessari, per chi non crede, ma non certo sufficienti: infatti gli occhi e le mani vedono e toccano la res significata, non la res significante.
Donare la pace e mostrare i fori è mostrare la condizione di acquisto della pace: la sofferenza, non la violenza. Cristo non è pacifico perché dona la pace; ma dona la pace appunto perché è pacifico. E la pace che Egli dona non è una pace qualsiasi, generica e retorica; ma è la sua pace: unica e nuova nella storia.
Non è la pace col nemico ottenuta dopo la vittoria sul nemico; ma la pace tra Dio e l’uomo che è il fondamento della nuova pace, di quella conquistata attraverso la sofferenza e l’agonia e che non si lascia smuovere neanche dal furbissimo mito della legittima difesa.
Il cristiano non si batte per fondare o per difendere la città terrena posta nell’ordine del divenire e della irrimediabile dissoluzione; ma si batte (accettando l’agonia e il martirio) per non perdere la cittadinanza della nuova città, discoperta, dal Cristo, che, posta com’è nell’ordine dell’essere, racchiuderà entro le sue mura tutti i dispersi figli di Dio, al di là di tutti gli stolti nazionalismi.
Cristo non è a servizio di nessuna civiltà; ma al servizio dell’uomo incastrato in qualsiasi civiltà. Cristo ha le sue vie libere al di là delle vie d’asfalto. Lui è la via libera offerta agli uomini chiusi entro il garbuglio feticistico delle tradizioni umane.
Adesso che, Lui è entrato a porte chiuse e ha consegnato come un dono la sua pace, tutti gli invasori umani, barbari e no, possono sfondare anche le porte. Il credente non avrà nulla da difendere se non la propria anima affinché non rimanga soffocata dalla corrente di odio che imperversa lungo i viali spaziosi delle piccole Gerusalemme terrene.
Pasqua 2025: Auguri a tutto il mondo. M.G.
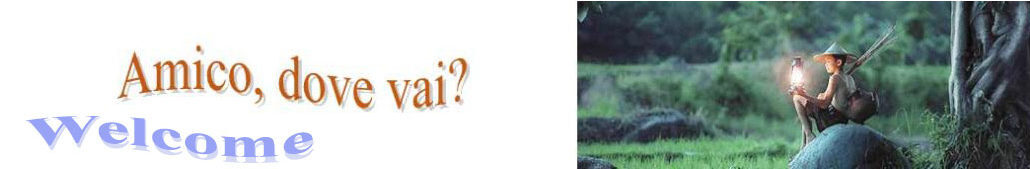
Unisciti alla discussione
Una risposta a “La Pasqua che egli dona”
Your style iis unnique in comparison to other flks
I’ve read stuff from. I appreciate yoou for posting wuen youu hve the opportunity, Guess I wiill just bookmark this page.